La musica rende liberi
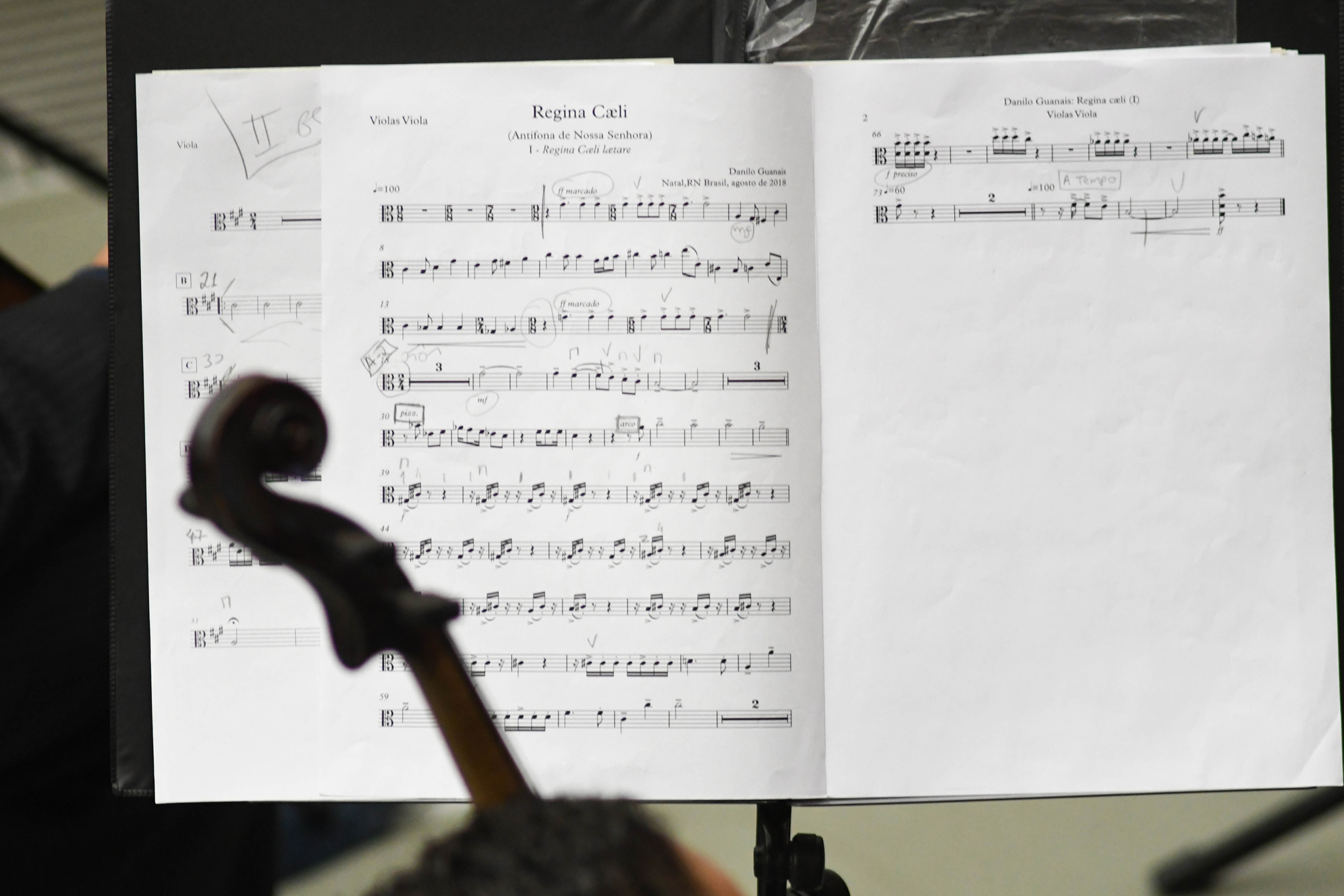
Le note uniscono i perseguitati nella guerra di ieri e di oggi
Oltre 14mila arresti in sessanta e passa città russe, secondo l’indipendente OVD-info, cartelli, fogli – anche solo bianchi – manifesti, grida, inni alla libertà dei popoli, e ovviamente placcaggi, percosse, prese sul collo, e galera. Non solo nell’occidente del ‘68, negli Usa dei drammatici giorni dopo assassinio di Martin Luther King, che fece parlare alcuni giornali di guerra civile, nella Cecoslovacchia dell’arrivo dei carri armati sovietici, ma anche in Cina e ora in Russia. La manifestazione ritorna come unico modo per la gente che non ha voce mediatica né altoparlanti sistemici per far sentire la propria voce. La voce di cittadini russi che si oppongono all’aggressione che il proprio paese ha iniziato e sta continuando contro un altro paese sovrano. La storia degli equilibri planetari si ripete, come in Vietnam e in altri luoghi del pianeta dove la forza delle spartizioni opprime quella delle singolarità e della utopica sovranità nazionale. E la storia delle manifestazioni e delle loro repressioni pure. I cartelli che inneggiavano alla pace nello spartiacque del ’68, e quelli contro la guerra in Vietnam nei primi Settanta, le urla e i sacrifici della propria vita dei giovani e non solo a Praga, e, ancora prima la crisi delle coscienze che spaccò l’intellettualità e la stessa militanza comunista in seguito all’invasione dell’Ungheria, e le manifestazioni di Solidarność in Polonia fanno oggi un effetto strano. Non appaiono più come espressione di un’inquietudine generazionale o addirittura di mode passeggere come qualche media allora sentenziò, ma come qualcosa di più drammaticamente legato alla vita, alla società e all’individuo. Alla vita stessa. La piazza di Chicago e di Washington rivendicava il diritto alla sopravvivenza, ad avere un lavoro come quello dei bianchi, a non doversi provare le scarpe nell’ultima fila del negozio riservata ai negri come era accaduto a Luther King bambino, a non dover cedere per forza il posto ai bianchi sui mezzi pubblici, ad avere lo stesso salario del bianco e poter usare gli stessi ascensori e bagni. Non solo sequele delle mode, come si vede.
Oggi quelle piazze rivendicano la pace, ma una pace giusta perché libera dallo straniero in armi. Come cantavano i Dire Straits in “Brothers in arms” negli Ottanta, e ancora prima gli Hollies, eravamo nei Sessanta, in una canzone dal titolo già di per se stesso profetico: “Non è un peso, è mio fratello”. Molto prima Bob Dylan in “Masters of war” aveva condannato profeticamente i padroni della guerra, rivolgendosi direttamente a loro: “voi caricate le armi/ che altri dovranno sparare/ e poi vi sedete e guardate/ mentre il conto dei morti sale/ voi vi nascondete nei vostri palazzi/ mentre il sangue dei giovani/ scorre dai loro corpi/ e viene sepolto nel fango”. Eravamo nel 1962, e questo vuol dire che purtroppo non molto è cambiato.
I giovani della contestazione avevano ripreso quelle canzoni, intonandole in piazza sotto gli striscioni. Soprattutto la mitica profezia di Blowin’ in the wind: “Quante orecchie deve avere un uomo prima che possa sentire la gente piangere? E quante morti ci vorranno perché lui sappia che troppe persone sono morte?”. Come qualche anno dopo cantava l’ex Beatle John Lennon in “Imagine”, resistere significava anche immaginare che non ci fosse “niente per uccidere o morire”, o parlare di altre forme di oppressione come gli Spandau Ballet di “Through the barricades” che ricordavano gli scontri tra indipendentisti cattolici, polizia e lealisti in Irlanda, e l’impossibilità finanche dell’amore in quella “terra desolata” che citava Eliot.
La piazza, la canzone, le poesie – la Terra desolata fu scritta pensando anche ai milioni di vittime della prima guerra mondiale – sembravano immagini che lentamente sarebbero state cancellate dalla virtualità digitale. C’è ancora vita, nonostante tutto.






